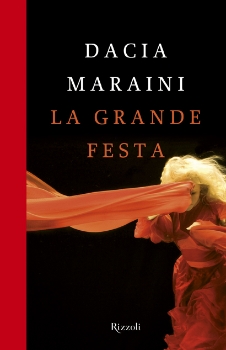Peter Shaffer: “Equus” – psicoanalisi e psichiatria in teatro – Eugen Galasso
In “Equus” del 1973 il drammaturgo inglese Peter Shaffer, autore anche, ma successivamente, di “Amadeus”, dove pur si sottolinea in chiave grottesca, ma non psichiatrizzante, l’ “altro” di Mozart con il suo “cachinno”, si parla poeticamente (ma il teatro è anche poesia visiva, più che scritta) di un ragazzo che aveva accecato dei cavalli, dove Shaffer era partito (lo scrive nella premessa al dramma) da un fatto di cronaca, immaginando il resto. Avendo lavorato da manutentore in una scuderia il ragazzo, innamorato di cavalli, aveva vissuto un’esperienza piacevole (“La prima volta” con una ragazza) interrotta dallo sguardo, per lui inquisitorio, di un cavallo bello, grande e imponente. Lo psicoanalista (ma è una sorta di impiegato da AUSL, salvo che il sistema sanitario inglese è molto diverso, anche se all’epoca era “socializzato”, perché governavano i Laburisti, quindi una via di mezzo tra psichiatra e psicoanalista), che lo “cura” è un frustrato per motivi familiari (rapporto conflittuale e di disprezzo verso la moglie) e progressivamente si accorge di essere inadeguato, in un climax che verso il finale lo porta allo scacco, al fallimento. Si inizia così: Dysart (lo psico):”Sogni molto?” Alan (ragazzo): “E lei?” Dysart: “Far domande è il mio lavoro. Tu pensa a rispondere”. Alan: “Chi lo dice? ” Dysart: “Lo dico io. Sogni molto?” Alan “E lei?” Dysart: “Andiamo Alan…” Alan: “Rispondo se risponde lei. Una volta per uno” (Pausa) Dysart: “Va bene. Ma dobbiamo sempre dirci la verità” Alan (con scherno): “Ci sto”. Dysart: “Sogni molto?” Alan: “Sì. E lei? ” Dysart: “Fa spesso lo stesso sogno?”. Alan: “No. E lei?”….(Atto nono, scena prima, op.cit., traduzione italiana, Genova, ediz. Teatro di Genova, terza edizione, 1974, p.31). Qui si vede come lo psicoanalista si limiti a una batteria di domande in stile inquisitorial-menefreghista, non rendendosi conto che l’altro glissa ogni sua domanda.
Idem quando (cit., oltre, a pp.53-54,scena sedicesima), vuol sapere se Alan aveva appuntamento con la ragazza e quando l’altro non glielo dice, si inalbera, gridando: “Dimmelo!” dove almeno una nota di rabbia, rancore e invidia non può non trapelare (come dire: “Lui sì, io no”), fino alla rabbia sorda ma non sciocca e non priva di ironia della sua messa a nudo -autodichiarazione dove dice: “Il Normale (sic!) è l’indispensabile e micidiale Dio della salute e io sono il suo sacerdote” (Scena 19.esima, p.60), per non dire di un finale feroce dove afferma ad Alan, gridando che lo libererà e che “Non soffrirai più. Non soffrirai quasi più (significativa diminutio, E.G.) affermando di aver un “disperato bisogno di trovare il modo di vedere nel buio” (Atto 2°, scena 35 , finale, a p.105). Shaffer, che è un grande del teatro, fa un po’ di confusione tra Freud (sorta di nuova “scena primaria” con il cavallo-padre-Superego castrante ma anche come simbolo archetipico di forza e bellezza insuperabile) ma la produzione di senso è assolutamente chiara, contro psichiatria e psicoanalisi velata da psichiatria…
Eugen Galasso
Pubblicato il 27 January, 2012
Categoria: Testi